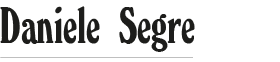Pierpaolo Loffreda/Il Corriere Adriatico
«Manila Paloma Blanca», primo lungometraggio girato espressamente per il grande schermo dal regista torinese Daniele Segre (uno dei pionieri, una decina d'anni fa, dell'eterogeneo e vivace «movimento» dei giovani film-makers italiani), e presentato qui nella sezione «Vetrina italiana», è un film bello, duro, sincero, d'immediato impatto emotivo e dotato di una singolare tensione espressiva. La storia narrata – colta direttamente dalla realtà, sceneggiata insieme a Davide Ferrano con piena consapevolezza dei ritmi narrativi e reinventata grazie ad una messa in scena originale – è quella di un ex-attore alla deriva che, dopo aver attraversato l'inferno dei ricoveri psichiatrici e della vita di strada, cerca disperatamente un reinserimento nella realtà, nel mondo degli affetti, di un'esistenza normale, per tornare quindi alle sue ossessioni, al suo disagio, alla sua dannata individualità.
Protagonista è Carlo Colmaghi, ex-attore teatrale alla sua prima esperienza cinematografica, che interpreta se stesso in modo toccante, estremamente convincente, dopo aver condiviso un percorso analogo a quello del suo personaggio (solitudine, emarginazione, logoramento dei rapporti con la vita e con la scena). II titolo del film non ha un senso specifico: è piuttosto un grido, un'imprecazione, un'invocazione disperata con la quale, nell' incipit shoccante, il protagonista proclama la sua irriducibile diversità, dà sfogo alle proprie paure e insieme tenta un rapporto col mondo.
La macchina da presa si muove in modo fluido, libero, scorrevole negli ambienti, elaborando piani sequenza incisivi, interrotti da primi piani onirici e stranianti del protagonista che, con lo sguardo torvo, spezza il flusso del racconto. Tutti i personaggi appaiono pienamente credibili, vengono tratteggiati con spessore e rappresentati in modo appassionato dall'autore, che riesce anche a scegliere e valorizzare al fini della resa drammatica ambienti quotidiani emblematici o poco frequentati, come la soffitta fatiscente in cui vive un altro emarginato (interpretato da Lou Castel), le case e i luoghi frequentati dalla buona borghesia, le mense assistenziali in cui si sfamano i barboni, la sinagoga di Torino. La follia è vista in modo crudamente realistico, a distanza ravvicinata, come rovina e disperazione e un'umanità disagiata, derelitta occupa il campo, finché non intervengono altri personaggi (come la donna ricca e colta di cui il protagonista si innamora e che lo prende con sé) che comunque non riusciranno a variare il destino segnato del protagonista, sempre in bilico fra disagio («Mi sento vuoto, nullo, solo, sempre più solo»), auto-rappresentazione (sincerità e recitazione tendono a confondersi), e ansia liberatoria di cambiamento.
Emerge evidente da parte di Segre (che aveva già utilizzato Colnaghi nel video-monologo «Tempo di riposo», presentato l'anno scorso a Bellaria e che in passato si era occupato altre volte di marginali «senza voce» come i travestiti e gli ultrà), l'assimilazione della lezione cinematografica di un grande maestro come Cassavetes, soprattutto nella resa efficace di un mondo che appare ricalcato sulla realtà dolente di ogni giorno.